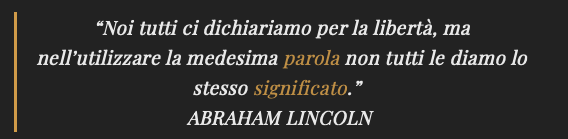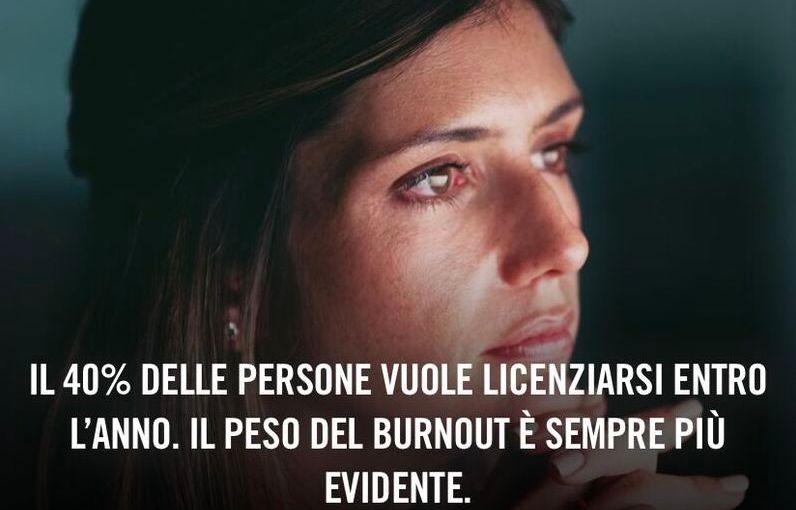Perché è così difficile dissuadere i complottisti dalle loro idee? Come mai in tanti si avvicinano alle teorie del complotto e, soprattutto, come mai finiscono per crederci? Sono domande che spesso mi sono posta e alle quali provo a dare una risposta in questo articolo.
La maggior parte delle disuguaglianze presenti nelle nostre società, come quelle di matrice xenofoba, sono il risultato di precise campagne d’opinione che nel tempo hanno trasformato enormi bugie nella base teorica dei pregiudizi di molti. Simone Fontana scrive su Wired che addirittura alcuni degli eventi più rilevanti degli ultimi anni sono potuti accadere anche grazie al decisivo contributo di notizie manipolate e operazioni di disinformazione su larga scala.
Per capire come funziona questo meccanismo non serve andare lontano. Ad esempio, in Italia è da anni che gli stereotipi più diffusi su migranti e rifugiati, come il fatto che godono di alberghi di lusso e 35 euro al giorno, pretendono il wi-fi e portano criminalità, sono utilizzati da alcuni politici per manipolare il consenso. Sono tutte fake news e pur essendo facilmente smentibili hanno un impatto molto forte sull’opinione pubblica.
Del resto è proprio questa la forza delle fake news: la disinformazione fa leva sulle paure e sugli stereotipi per alimentare pregiudizi e polarizzare il dibattito. Inoltre, se questa manipolazione è sfruttata, se non prodotta, da una parte della politica, è inevitabile che abbia un’importante influenza sulla vita delle persone coinvolte e sul modo che gli elettori hanno di vedere il mondo. Ed è anche grazie a queste manipolazioni che l’opinione pubblica sostiene o meno campagne a favore o contro determinate proposte di legge o politiche.
I meccanismi di disinformazione basati sulle fake news e sulla semplificazione di vicende complesse ai quali siamo continuamente sottoposti sono gli stessi che animano le teorie del complotto.
Il celebre storico Yuval Noah Harari spiega che le teorie del complotto non sono state inventate da QAnon, ma esistono da migliaia di anni e la loro forza si trova nella semplificazione della realtà. Di fronte a guerre, rivoluzioni, crisi e pandemie quando si crede in una teoria del complotto sotto questa miriade di eventi complessi si nasconde un unico gruppo sinistro che controlla il mondo.
Le teorie del complotto sono quindi in grado di attrarre un gran numero di seguaci proprio perché offrono una spiegazione unica e diretta a innumerevoli processi complicati offrendo la confortante sensazione di capire tutto. Non solo, credere in una teoria del complotto offre l’ingresso in un circolo esclusivo – il gruppo di persone che capiscono. Al di sopra non solo dell’uomo medio ma anche dell’élite intellettuale e della classe dirigente che trascura, o nasconde, la verità.
La guerra in Siria? Non ho bisogno di studiare la storia del Medio Oriente per capire cosa sta succedendo lì. Fa parte della grande cospirazione. Lo sviluppo della tecnologia 5G? Non ho bisogno di fare alcuna ricerca sulla fisica delle onde radio. È la cospirazione. La pandemia di Covid-19? Non ha niente a che fare con ecosistemi, pipistrelli e virus. Fa ovviamente parte della cospirazione.
Seguendo questo ragionamento, Harari sostiene che anche il nazismo era fondamentalmente una teoria del complotto basata su una bugia antisemita: «Una cabala di finanzieri ebrei domina segretamente il mondo e sta tramando per distruggere la razza ariana. Hanno architettato la rivoluzione bolscevica, gestiscono le democrazie occidentali e controllano i media e le banche. Solo Hitler è riuscito a vedere attraverso tutti i loro trucchi nefasti – e solo lui può fermarli e salvare l’umanità».
Hitler ha intercettato lo stato d’animo di generale frustrazione che serpeggiava nel popolo tedesco e il desiderio di riscatto dopo l’esito della Prima Guerra Mondiale e la Grande Depressione ed è stato capace di trovare una spiegazione unica e diretta al malumore tedesco: l’enorme bugia antisemita.
Se le teorie del complotto sono basate su enormi bugie, allora perché in tanti ci credono?
Sempre lo storico israeliano Harari spiega che anche se ci sono molte cospirazioni reali nel mondo – individui, società, organizzazioni, chiese, fazioni e governi – che covano e perseguono costantemente vari complotti, esse non fanno parte di un unico complotto globale e la loro molteplicità rende impossibile pensare che prevedano e controllino il mondo nella sua interezza.
In sostanza, il mondo è molto più complicato di come è dipinto da una teoria del complotto e infatti le ragioni che portano a credere in una di esse non sono di carattere razionale ma psicologico.
La prima ragione, già menzionata, è legata al fatto che credere in una teoria del complotto fa sentire le persone “speciali” perché più informate degli altri su eventi sociali e politici importanti.
Tra gli fattori che avvicinano alle teorie del complotto, Focus riconosce la tendenza che ogni essere umano ha a distinguere pattern ricorrenti e regolarità anche dove non ci sono. Una qualità che ci ha aiutati per millenni a salvarci dai predatori ma che può portare a percepire imbrogli e raggiri anche dove non esistono.
Influisce anche il bisogno di ricercare continuamente l’approvazione sociale. Spesso sembra più conveniente risultare socialmente interessanti e desiderabili che dire cose corrette, soprattutto se molti amici e contatti la pensano in un determinato modo.
A questo si collega anche il bias di conferma, cioè la tendenza a cercare sempre la conferma dei propri pensieri e idee quando ci si confronta con gli altri. Se il metodo scientifico ha il compito di contrastare questo pregiudizio, ad esempio i politici e i quotidiani che si decide di seguire “perché dicono le cose come stanno” non faranno che confermarlo.
Dunque, le teorie del complotto non sono razionali, proprio perché sono basate su una enorme bugia, e spesso la scelta di credere in una di esse è collegata all’approvazione sociale. Ciò significa che le teorie del complotto sono sostenute dalle persone che in esse credono, non dai fatti o dalla logica.
Per contrastare il fenomeno del cospirazionismo non basta allora saper individuare le teorie del complotto. Infatti quando la disinformazione diventa la cifra dell’appartenenza a un gruppo sociale è molto più difficile dissuadere con prove scientifiche le persone dalle loro false credenze, proprio perché queste ultime sono fondate sul piano relazionale ed emotivo e non sul pensiero logico e razionale tipico della scienza.
Immagine “The Pigpen Cipher” di Matthew Phelan.